Quando si pensa a Napoli, spesso vengono in mente il Vesuvio che domina il Golfo, i vicoli del centro storico, il presepe, il fermento popolare e le grandi chiese iconiche come il Duomo, Santa Chiara, San Domenico Maggiore. Ma c’è un’altra Napoli, quella dei silenzi, delle ombre, delle chiese nascoste: le chiese dimenticate di Napoli che custodiscono opere d’arte, storie sepolte, spaccati di fede e miti locali che attendono chi voglia avventurarsi oltre i percorsi battuti.
Esplorare questi angoli sacri significa scoprire luoghi sacri da scoprire a Napoli che parlano del tempo lontano, dei tumulti di una città in trasformazione, di voci che il tempo ha attenuato ma non cancellato. In questo articolo guiderò il lettore dentro cinque di queste chiese “nascoste”, partendo da due esempi emblematici: la Chiesa di Santa Maria Maddalena ai Cristallini e la Chiesa di San Giovanni a Carbonara.
Chiesa di Santa Maria Maddalena ai Cristallini
La Chiesa di Santa Maria Maddalena ai Cristallini sorge in Via dei Cristallini, nel quartiere San Carlo all’Arena. Non è tra i luoghi più citati nelle guide turistiche, ed è proprio questo il suo fascino discreto: uno dei gioielli nascosti tra le chiese dimenticate Napoli.
L’edificazione attuale risale al 1851, realizzata sulla base di strutture preesistenti che erano appartenute al “Ritiro delle Pentite di San Raffaele” a Materdei, grazie a donazioni private e spettacoli di beneficenza nei teatri cittadini.
Durante i bombardamenti del 1943 la chiesa subì gravi danni e, negli anni successivi, l’interno fu modificato sensibilmente. Solo recentemente è stato completato un restauro che ha trasformato lo spazio in una sorta di “set” d’arte contemporanea, integrando installazioni, interventi pittorici e un recupero simbolico dell’ambiente sacro.
Architettura e punti di interesse
La facciata è sobria: timpano triangolare e bugnato sulle pareti. Il portale, protetto da una scala in piperno, introduce all’interno che è a navata unica, con volta a botte e cappelle laterali.
All’altare maggiore un tempo era presente una tela raffigurante la Maddalena, opera del pittore Nicola La Volpe, trafugata da tempo; mentre la statua lignea dell’Addolorata, anch’essa ottocentesca, è tornata a occupare il suo posto nel 2023.
Questa chiesa, in potenza, è un perfetto esempio di come anche luoghi sacri da scoprire a Napoli possano diventare vere e proprie “stanze dell’anima”, capaci di unire passato e presente in una forma sottile di sacralità contemporanea.
Chiesa di San Giovanni a Carbonara
Tra le chiese dimenticate Napoli, poche sono così ricche di stratificazioni storiche, ambizioni politiche e decorazioni celebri come la Chiesa di San Giovanni a Carbonara. Passeggiando da Porta Capuana verso l’area di via Carbonara, la sua facciata appare modesta ma non lasciarti ingannare: è la soglia di un complesso spettacolare.
Le origini: luogo e denominazione
La chiesa e il complesso conventuale furono fondati tra il 1339 e il 1343, grazie al dono del nobile Gualtiero Galeota all’ordine degli Agostiniani, con la condizione che fosse dedicata a San Giovanni Battista.
Il nome “Carbonara” deriva dal fatto che l’area su cui sorgeva era nota come “Ad Carbonetum” o “Carbonarius”, un luogo fuori dalle mura dove venivano smaltiti i rifiuti e il carbone.
L’edificio fu completato, ampliato e decorato nel corso del XV secolo, in particolare per volontà di re Ladislao d’Angiò-Durazzo, che volle trasformarlo in una sorta di pantheon dinastico per gli Angioini.
Architettura, accessi e decorazioni
Una delle caratteristiche più scenografiche è lo scalone monumentale a tenaglia, concepito nel Settecento dall’architetto Ferdinando Sanfelice per collegare la quota stradale all’ingresso degli ambienti sacri sottostanti.
L’ingresso principale è un portale gotico del Quattrocento, mentre l’interno è impostato su una pianta a croce latina con una sola navata centrale e cappelle laterali (due per lato), oltre a una cappella nella controfacciata (Cappella Somma) e la Cappella Caracciolo del Sole alle spalle dell’abside.
Tra le opere più note vi è il monumento funebre di re Ladislao, con imponenti figure allegoriche, scolpito da Andrea da Firenze tra il 1414 e il 1420. Il monumento culmina con la statua equestre del re e costituisce un passaggio stilistico tra il gotico e il Rinascimento.
Nella Cappella Caracciolo del Sole si trova il monumento di Sergianni Caracciolo, celebre amante della regina Giovanna II, con sculture di derivazione fiorentina e influenze lombarde.
Tra gli altri elementi notevoli, si ricordano affreschi della scuola lombarda (come quelli di Leonardo da Besozzo nella lunetta del portale), il celebre dipinto della Crocifissione di Vasari commissionato da Seripando, e cappelle gentilizie (Caracciolo di Vico, Somma, Miroballo) con ricche decorazioni rinascimentali.
Con il passare del tempo, il complesso ha sofferto modifiche e fasi di restauro che ne hanno alterato alcune parti, ma la grandiosità della concezione originaria e le stratificazioni artistiche fanno di San Giovanni a Carbonara un must per chi cerca luoghi sacri da scoprire a Napoli con un’anima storica profonda.
Chiesa di Santa Maria della Stella
Tra le chiese dimenticate Napoli, la Chiesa di Santa Maria della Stella è un gioiello che racconta fermenti religiosi, trasformazioni architettoniche e tragedie che l’hanno segnata. È situata in Piazzetta Stella, nel quartiere che porta lo stesso nome.
La chiesa fu fondata nel 1571 per custodire un’immagine della Vergine, precedentemente collocata presso Porta San Gennaro, su un colle che dominava il vallone della Sanità. Successivamente l’ordine dei Minimi acquisì l’edificio e lo fece ricostruire a partire dal 1587 su progetto di Domenico Fontana. Nei decenni successivi vi furono numerosi rimaneggiamenti, specialmente nel XVII secolo: la facciata in piperno e marmo fu iniziata da Bartolomeo Picchiatti e ultimata nel 1734 da Domenico Antonio Vaccaro.
Potrebbe interessarti
Un evento tragico segnò la chiesa: nel 1944 un incendio distrusse gran parte della decorazione interna e danneggiò opere preziose. Alcune opere andarono perdute, ma il restauro successivo recuperò e reimpiegò elementi artistici provenienti da altre chiese distrutte.
Il complesso include anche l’ex-convento: in seguito alla soppressione degli ordini religiosi (1861) grandi parti furono destinate a funzioni militari, come la Caserma Podgora.
Architettura, opere e punti di interesse
La pianta è rettangolare con transetto e cinque cappelle per lato lungo l’unica navata. Il soffitto a cassettoni, decorato con vernici oro e toni cobalto, è particolarmente scenografico. Nelle cappelle laterali e nel presbiterio si incontrano opere pregevoli: tele di Pietro del Pò (provenienti da Castel Nuovo), e l’unico dipinto originale sopravvissuto all’incendio, una pala di Battistello Caracciolo che raffigura l’Immacolata con santi Domenico e Francesco (1607). In antico nella facciata era inserito un affresco della “Madonna della Stella tra i santi Gennaro e Francesco di Paola”, oggi non più visibile.
Anche il busto marmoreo del vescovo Luigi Riccio (†1643) merita attenzione, collocato nell’antisacrestia come elemento commemorativo.
Nel corso dei secoli intervennero architetti del calibro di Arcangelo Guglielmelli, Giovanni Battista Nauclerio, Dominique Vaccaro e Ferdinando Sanfelice nella ristrutturazione della chiesa e del convento. Subì danni anche durante i bombardamenti della Seconda guerra mondiale.
Basilica di San Pietro ad Aram
La Basilica di San Pietro ad Aram è forse una delle chiese dimenticate Napoli che più unisce mito, tradizione e stratificazione archeologica. È situata vicino a Corso Umberto I, nel cuore del centro storico, in una zona spesso affollata e attraversata dai flussi cittadini.
Leggenda, mito e funzione sacra
Secondo la tradizione, San Pietro predicò in questo luogo durante il suo viaggio a Napoli e qui innalzò un altare (“Ara Petri”) tra il 43 e il 44 d.C. In questo stesso punto avrebbe battezzato i primi napoletani convertiti: Santa Candida e Sant’Aspreno. Per queste ragioni, l’edificio ha acquisito una dimensione simbolica molto forte nella spiritualità cittadina.
Nel corso del Cinquecento il pontefice concesse alla chiesa il privilegio di celebrare giubilei locali, un modo per dare sollievo ai fedeli che non potevano recarsi a Roma. Tuttavia, tale privilegio fu abolito nei secoli successivi.
Architettura, scoperte archeologiche e tesori
L’attuale struttura risale al XVII secolo, costruita fra il 1650 e il 1690 su progetto di Pietro De Marino e Giovanni Mozzetta. Il layout è a pianta a croce latina, con navata centrale, cappelle laterali e un’abside.
Tra le decorazioni interne figurano tele e opere di artisti come Luca Giordano (per es. “San Pietro e San Paolo si abbracciano prima del martirio”) e altri pittori locali come Giacinto Diano, Andrea Vaccaro, Nicola Vaccaro, Sarnelli, Pacecco De Rosa. Il baldacchino marmoreo progettato da Giovan Battista Nauclerio protegge l’antico altare.
Un elemento particolarmente suggestivo è l’ipogeo sottostante: la basilica conserva una cripta paleocristiana a tre navate, scoperta durante lavori interni e identificata come parte dell’antica struttura originaria. In alcuni ambienti ipogei si possono vedere celle, ambienti funerari e tracce di antiche basiliche.
Non basta: nell’area sotto la chiesa sono stati rinvenuti resti scheletrici, che la leggenda ha associato a Santa Candida (una delle prime fedeli locali) e ad altre “anime”: alcune pratiche devozionali legate alle “anime del Purgatorio” si sono sviluppate proprio in questo contesto, in analogia con il culto noto nel Cimitero delle Fontanelle.
La facciata esterna è relativamente sobria, mentre l’ingresso si raggiunge scendendo alcuni gradini verso l’interno, accentuando l’idea di un ingresso “verso il tempo sotterraneo”. È interessante notare che il portale proviene dal Conservatorio dell’Arte della Lana (Vico Miroballo).
Infine, anche il contesto urbano ha influito: il chiostro originario e gli spazi conventuali sono stati in gran parte demoliti nel corso del Risanamento ottocentesco per la costruzione di Corso Umberto, con conseguente perdita parte della struttura originaria.
In questo modo San Pietro ad Aram rimane un luogo in cui mito, memoria e stratificazione architettonica si incontrano, rendendolo uno dei luoghi sacri da scoprire a Napoli più carichi di atmosfera.
Fonte Verificata





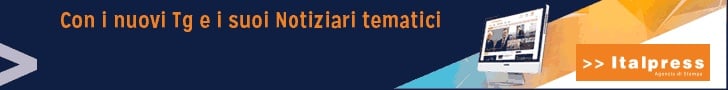

Commenti (1)
L’articolo parla di chiese dimenticate a Napoli, e sono luoghi che non si vedono spesso nelle guide turistiche. Però ci sono molte storie e opere d’arte che meritano di essere scoperte, anche se non sempre sono facili da trovare.